L’Italia è stato uno dei primi paesi occidentali ad aprire le porte all’animazione giapponese, comunemente conosciuta come anime. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, oltre un centinaio di serie furono importate, sia dalla Rai che dalle emittenti private liberalizzate nel 1976, come le reti che sarebbero diventate Fininvest. Questa massiccia introduzione è stata definita una pacifica “invasione” culturale.
La penetrazione degli anime in Italia iniziò con la proiezione di lungometraggi nei cinema già dai primi anni ’60.
Il primo film anime a uscire nelle sale italiane fu Le 13 fatiche di Ercolino (Saiyuki) nel 1962. Seguirono altri classici come Le meravigliose avventure di Simbad (1964), Le meravigliose favole di Andersen (1968), La grande avventura del piccolo principe Valiant e Il gatto con gli stivali (1969), e Leo – Il re della giungla (1972), un montaggio della serie Kimba – Il leone bianco. Questi film venivano spesso proiettati durante le matinée domenicali o presentati come prodotti americani.
La svolta decisiva nella diffusione degli anime in Italia avvenne nella seconda metà degli anni ’70, con l’importazione di serie televisive.
La diffusione degli anime in Italia ha avuto una svolta decisiva nella seconda metà degli anni ’70, un periodo in cui il piccolo schermo ha iniziato a presentare al pubblico nostrano un affascinante e variegato universo di animazione giapponese. Il 15 settembre 1975 segna una data storica: la televisione svizzera in lingua italiana inizia a trasmettere Barbapapà, seguita dalla Rete 2 Rai nel gennaio 1976. Questa serie rappresenta il primo anime giapponese ad essere trasmesso in Italia, aprendo la strada a una serie di successi che definiranno un’intera generazione.
Nei successivi anni ’70, altre celebri produzioni giapponesi come Vicky il vichingo (1976), Kimba – Il leone bianco (1977), Heidi e Atlas UFO Robot (1978) conquistano il pubblico, cementando l’immagine degli anime come intrattenimento per giovani. In questo contesto, l’Italia si trova a vivere un’epoca di grande entusiasmo per i “cartoni animati”, che vengono programmati nelle ore mattutine e pomeridiane, spesso soggetti a censure e trasposizioni dei nomi in italiano. Malgrado queste limitazioni, gli appassionati di quell’epoca ricordano con affetto le sigle di queste serie, molte delle quali hanno contribuito a lanciare carriere di artisti italiani.
Gli anni ’80
Gli anni ’80 rappresentano l’apice della crescita economica del Giappone, un periodo noto come “la bolla”, durante il quale il Paese si afferma come superpotenza economica. Questa rinascita si riflette anche nel panorama dell’animazione, che diventa sinonimo di innovazione e creatività. Tuttavia, mentre all’estero gli anime sono spesso considerati prodotti esclusivamente per bambini, in Italia si iniziano a scoprire sfumature più profonde, con trame complesse e personaggi articolati.Una delle icone indiscusse di questo periodo è Lupin III, la cui prima trasmissione avviene nel 1979. Questo ladro gentiluomo, creato dalla matita di Monkey Punch, diventa rapidamente un simbolo della cultura pop giapponese. Con il suo carisma e le sue avventure rocambolesche, Lupin, insieme ai suoi inseparabili compagni Jigen e Goemon, rapisce il cuore degli spettatori italiani. Nonostante le censure che hanno alterato molte delle sue avventure, la sua popolarità non ha conosciuto tregua, continuando a vivere in nuove serie e lungometraggi.Altro esempio emblematico è Candy Candy, trasmesso nel 1980, che racconta le disavventure di una ragazza orfana in cerca di amore e accettazione. Questo anime, insieme a Georgie (1984), entra nel cuore degli spettatori con trame drammatiche e intense, segnando il debutto del genere shoujo in Italia. Le storie di Candy e Georgie, con le loro emozioni e drammi, offrono uno spaccato dell’adolescenza e delle sfide che i giovani devono affrontare, catturando l’attenzione e l’affetto di un pubblico vasto.Anche Lady Oscar, trasmesso nel 1982, si distingue come un’opera di grande successo, raccontando le avventure di una giovane donna cresciuta come un uomo nel contesto tumultuoso della Francia pre-rivoluzionaria. La serie, che ha riscosso un’accoglienza calda in Italia, è riuscita a conquistare anche le classifiche musicali grazie alla sua sigla, un chiaro segno dell’impatto culturale che gli anime avevano cominciato a esercitare nel Paese.Con l’arrivo di Lamù (1984), il panorama si arricchisce ulteriormente, introducendo elementi di commedia romantica e situazioni surreali, che conquistano un pubblico giovanile affamato di storie nuove. Questo anime, pur essendo caratterizzato da scene provocatorie, non subisce censure e rappresenta un caso unico nel panorama dell’animazione italiana.La fine degli anni ’80 segna l’apice della popolarità degli anime con Kiss Me Licia (1985) e Ken il Guerriero (1987). Mentre il primo racconta una dolce storia d’amore tra adolescenti, il secondo esplora tematiche più violente e adulte, mostrando il volto più crudo della vita in un mondo post-apocalittico. Questa dualità nelle trame dei cartoni giapponesi rende evidente la varietà e la complessità dell’animazione nipponica.Infine, È quasi magia, Johnny (1989), con la sua narrazione leggera e le sue dinamiche amorose, conclude un decennio ricco di scoperte e innovazioni nel campo dell’animazione. Sebbene i titoli di quegli anni siano oggi nostalgici ricordi, rappresentano anche il primo passo verso una maggiore accettazione e apprezzamento degli anime come un genere artistico capace di raccontare storie universali.
La censura ha giocato un ruolo cruciale nell’adattamento degli anime in Italia, portando a traduzioni superficiali e a modifiche delle trame originali. Ciò ha generato un malinteso culturale che ha relegato l’animazione a un mero prodotto infantile, dimenticando la ricchezza e la profondità che questi racconti potevano esprimere. Tuttavia, il fervore dei fan ha garantito che, anche in un contesto di censure, gli anime continuassero a vivere nei ricordi e nelle passioni di intere generazioni.
Second Impact: La Rinascita degli Anime in Italia
Nella seconda metà degli anni ’90, il mercato home video contribuì a colmare il ritardo nella distribuzione di nuovi anime in Italia, fenomeno definito come il “Second Impact” dell’animazione giapponese. Dal 1999, reti nazionali come MTV Italia iniziarono a trasmettere regolarmente anime, grazie ad accordi con editori italiani come Dynit, Panini Video e Shin Vision. Questo periodo vide l’introduzione di maratone e settimane tematiche dedicate agli anime, che contribuirono a una maggiore diffusione e apprezzamento di questo medium.
L’Era Digitale e l’Impatto Culturale
Con l’avvento della televisione digitale terrestre e di internet, l’accesso agli anime si ampliò ulteriormente. Reti come Rai 4 iniziarono a trasmettere anime in versione integrale, mentre piattaforme digitali come Man-ga e Anime Gold offrivano canali tematici dedicati. Negli ultimi anni, internet è diventato un canale distributivo globale per gli anime, attraverso servizi di streaming legali e, purtroppo, anche tramite la diffusione illecita di contenuti sottotitolati da gruppi di fansub.
L’animazione giapponese ha avuto un profondo impatto sulla cultura giovanile italiana, diventando un punto di riferimento generazionale e creando quella che si definisce come “JCulture“.
Le sigle degli anime, spesso realizzate da musicisti italiani come Vince Tempera e Cristina D’Avena, sono diventate un fenomeno discografico a sé stante. Questo ha contribuito a un revival delle sigle negli anni ’90, con l’emergere di gruppi musicali dedicati e un rinnovato interesse per queste melodie nostalgiche. L’invasione degli anime in Italia ha rappresentato un fenomeno culturale di vasta portata, con un impatto duraturo sulla cultura popolare e giovanile. Nonostante le controversie e le censure, gli anime hanno trovato un pubblico affezionato e hanno contribuito a una maggiore comprensione e apprezzamento dell’animazione giapponese come forma d’arte.





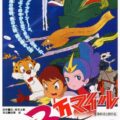













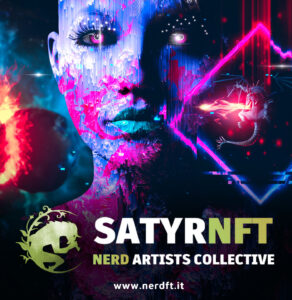



















Aggiungi commento